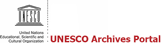Le Grotte delle Fate sono una cava sotterranea di Epoca Arcaica.
Durante la lunga fase delle Guerre di Roma contro Veio (509-396 a.C. circa) le grotte segnano, con alterne vicende, il confine territoriale fra le due città-stato: entrambe le culture vi collocano la residenza del dio Silvano (Selvans per gli Etruschi, Silvanus per i Latini). La frequentazione moderna è attestata da un contratto del 1451, e ancora nel 1547, nella mappa di Eufrosino della Volpaia. Ai primi del Novecento le grotte diventano rifugio antiaereo annesse al Genio militare. Si ipotizza che le grotte fossero unite con con gli edifici in superficie: le torri Cocchi e di Papa Leone, Villa Kock e il Casalone, e le più recenti Torre Righetti, Villa Usai e Villa Baccelli.
I Sette Pagi
Veio è una città-stato etrusca, nata nel X sec. a.C., una ventina di chilometri a nord del Palatino. È una cittadina tutto sommato piccola (si pensi alle già fiorenti Tarquinia, Vulci, Caere); tuttavia ha caratteristiche destinate a farne per più secoli la più irriducibile avversaria di Roma. Sorge infatti su un altopiano fortificato, protetto da 8 km di mura e da un lago artificiale; gode dell’alleanza religiosa e militare delle città della koinè etrusca; e soprattutto Veio si trova sul crocevia di due grandi rotte commerciali: quella lungo il Tevere, da cui Fenici e Greci risalgono nell’entroterra; e quella tra nord e sud Italia, cioè tra mondo etrusco e un mondo ancora tutto in formazione, da cui emergeranno i Latini e Roma.
In questa situazione privilegiata la piccola Veio consolida nel IX secolo a.C. il suo potere sulla riva destra del Tevere, per un tratto di circa 30 km, dall’attuale Monte Mario fino alla foce, a cui Plinio il Vecchio, nella sua Naturalis Historia (III, 53), darà il nome di «Ripa Veiens». La Ripa Veiens ha una geografia piuttosto semplice. Ad est c’è una cittadella fortificata con poderose mura (di recente identificata con il grande «oppidum» di Colle Sant’agata a Monte Mario). La seguono, procedendo verso ovest lungo il Tevere, alcuni popolosi insediamenti fortificati: ve n’era uno nell’Ager Vaticanus, un altro sul Gianicolo, ed un altro nell’ordierno Trastevere.
Superato Trastevere non ci sono più insediamenti stanziali, ma 7 avamposti militari a presidio del Tevere, con relative stazioni commerciali. I navigatori greci chiamano questi sette presìdi «Ἑπτὰ Πάγοι» (Epta Pagoi) e più tardi i Latini li chiameranno «Septem Pagi», cioè i sette villaggi. Su di essi però le fonti sono avare: uno di essi di chiamava «Careia» e presidiava il Rio Galeria, affluente di destra del Tevere. Probabilmente ce n’era un altro chiamato «Allias» a guardia del Rio Magliana, e più probabilmente c’era un avamposto per ogni foce di corso d’acqua di una qualche entità (navigabile), che mettesse in comunicazione diretta il Tevere con l’interno. Una certa importanza doveva avere anche il Rio Affogalasino, che è il primo fiumiciattolo navigabile dopo il Gianicolo: gli archeologi, è opportuno dirlo, non vi hanno trovato finora alcun insediamento etrusco; e tuttavia hanno riconosciuto, nella Collina di Monte Cucco che domina l’estuario del Rio Affogalasino nel Tevere, un vistoso sbancamento attribuibile ad una cava di tufo in blocchi e polvere di pozzolana, a cielo aperto, che affonda le sue origini in Epoca arcaica. La cava presenta ampi tratti in galleria, che in alcuni punti si aprono in cameroni ipogei ancora oggi presenti. Giunti alla foce del Tevere troviamo l’ultimo degli insediamenti etruschi, a guardia delle saline costiere.
Veio sviluppa floridi commerci lungo il Tevere, basati soprattutto sul sale, che scambia con Greci e Fenici per ceramiche e tessuti. I Veienti, nella ricchezza di beni materiali, possono dedicarsi così all’attività preferita della cultura etrusca: la «bella vita», fatta di pace e prosperità.
Roma, l’«antipolis» di Veio
A metà dell’VIII sec. a.C. si affaccia però sulla scena un rozzo e prepotente villaggio di pastori sul Colle Palatino: Roma. Non ci vuole molto per i Veienti per capire che Roma, speculare a Veio sulla riva sinistra del Tevere, è il suo doppio, uguale e opposto. Per dirla con le parole degli storici è la sua «antipolis»: la prosperità Roma significa la povertà di Veio, e viceversa.
È Veio ad aprire le ostilità con Roma nel 750 a.C., secondo i racconti degli storiografi Tito Livio e Plutarco, che si intrecciano con la leggenda della fondazione di Roma. Il suo fondatore, Romolo, ha da poco occupato il villaggio etrusco di Fidene. E Veio, riporta Livio dei suoi Ab Urbe condita Libri (I, 15), in ragione del «comune sangue etrusco» prende le armi contro Roma. Dopo alterne vicende Romolo riporta una netta vittoria, e insegue i Veienti fino sotto le loro mura. Il trattato di pace che ne segue consente ai Romani una prima penetrazione commerciale nei Sette Pagi e nelle Saline, e porta con sé una tregua («indutiae») della durata di 100 anni. La «Silva Moesia» (letteralmente: il bosco di mezzo che abbraccia tutto il Territorio Portuense), rimane invece sotto l’esclusivo controllo etrusco.
Il successore di Romolo, il pacifico Numa Pompilio, rispetta la tregua. Qualche scaramuccia c’è al tempo del re Tullo Ostilio, che, impegnato in azioni di guerra contro i Sabini, presta il fianco ai Veienti per alcune azioni di brigantaggio. Ma non si arriva allo scontro aperto, perché la tregua dei cento anni è ancora valida. Riporta Livio (I, 30): «Valuit pacta cum Romulo indutiarum fides», prevale il rispetto dei patti di tregua stipulati con Romolo.
Con il bellicoso Anco Marzio la tregua scade. Livio non è preciso nel dirci come Anco Marzio abbia fatto guerra ai Veienti. Si limita a riassumene l’esito (I, 33): «Silva Maesia Veientibus adepta, usque ad mare imperium prolatum», la Selva di mezzo viene strappata ai Veienti, e il potere di Roma si estende sino al mare. Alla foce Anco Marzio fonda peraltro la prima colonia romana: «in ore Tiberis Ostia urbs condita, Salinae circa factae», e lì vicino crea le Saline.
Con i successori, i tre «Re Tarquini», Roma finisce per un centinaio di anni sotto il protettorato della città etrusca di Tarquinia. Per Veio questo periodo coincide con un secolo di tranquillità, in cui i Veienti commerciano indistrubati lungo le rive del Tevere, in coabitazione coi Romani. Non era difficile, per le campagne portuensi, incontrare sia Etruschi che Romani, che certo non nutrono simpatie reciproche, ma in questo periodo si sopportano senza grossi problemi. Al tempo di Servio Tullio, a dire il vero, succede che una tregua pluriennale scade senza essere rinnovata. Immediatamente Servio Tullio muove un esercito verso Veio e ha qualche successo militare, ma la guerra si conclude con quache ritocco del confine e una nuova tregua pluriennale.
La guerra stanca
La cacciata dell’ultimo re, Tarquinio il Superbo, segna l’inizio di un secolo di guerra vera.
Nel 509 a.C., riporta Terenzio Varrone, i Romani pongono fine al protettorato di Tarquinia e instituiscono la magistratura dei consoli, con il compito di guidare la nuova Res Publica. Uno dei primi consoli, Publio Valerio Publicola, si ritrova a fronteggiare un esercito di Veienti in marcia verso Roma. Riporta Livio (II, 6): «Veientes … amissa repetenda minaciter fremunt», i Veienti femono minacciosi per riprendersi la terra persa. Publio Valerio Publicola, sperimentando con successo la tecnica militare della fanteria ordinata in «quadrati», disperde i Veienti. Facendo un po’ di umorismo Livio racconta: «Veientes, vinci ab romano milite adsueti, fusi fugatique», i Veienti vengono dispersi e messi in fuga, ma d’altronde erano già abituati a prenderle dai Romani.
Sulla scena entra intanto il re etrusco Porsenna, Lucumone di Chiusi. A Porsenna di Veio importa ben poco: gli importa invece di porre un freno all’espansione di Roma nell’entroterra. Porsenna ha qualche successo, al punto di costringere i Romani ad un onorevole accordo, di cui finiscono per beneficiare i Veienti. Nel «Trattato del Gianicolo» si riassegna infatti la riva destra per intero agli Etruschi, con la sola esclusione del Gianicolo e delle Saline, che restano ai Romani.
Ne segue un periodo di relativa tranquillità, in cui anche le croniche tensioni tra il patriziato e la plebe di Roma paiono trovare una composizione in leggi eque. Una di queste ad esempio nazionalizza il sale: «Salis quoque vendendi arbitrium in publicum omne suntum, ademptum privatis», il commercio del sale viene tolto all’arbitrio dei privati ed avocato a sé dallo Stato (Livio, II, 9). Un nuovo nemico esterno, i Volsci, concede ai Veienti l’ennesimo periodo di tregua.
Con i Volsci, a cui si aggiungono anche Equi e Sabini, la guerra è dura. Al punto che Roma precipita in una lunga fase di miseria. Tra i plebei molti vengono colpiti dal «nexum», la riduzione in schiavitù per debiti, e la plebe, in risposta, si ritira sull’Aventino. I Veienti approfittano largamente della debolezza interna di Roma, e alimentano continue scorribande in territorio romano, con modalità simili al moderno brigantaggio. Roma da parte sua sopporta con pazienza le scorribande dei Veienti: c’è qualche combattimento quando i Veienti si fanno troppo vicini, prepotenti o avidi ma, una volta respinti e costretti a precipitose ritirate entro le mura di Veio, non c’è una seria volontà di inseguirli né dar vita alla «dimicatio ultima», la battaglia risolutiva.
Silvano, dio della frontiera
È utile, a questo punto, parlare di una figuretta minore del pantheon arcaico di Roma, comune con il pantheon etrusco, che secondo la tradizione prende parte all’interminabile e poco virile disputa tra Etruschi e Romani.
Vuole la tradizione che in ampie grotte su Tevere, che non è difficile identificare proprio con le grotte di Monte Cucco, abbia risieduto il dio agreste Silvano. Più precisamente, secondo gli Etruschi abita qui il dio Selvans, e secondo i Romani abita qui il dio Silvanus: ma si trattava per entrambi della stessa divinità. Di un sacrificio a Silvano compare tra l’altro traccia anche negli Atti degli Arvali (redatti in epoca imperiale), testimoniandone tra l’altro una certa longevità nel culto. Dunque, secondo la tradizione, Silvano è una divinità rurale, che presiede alle selve e alle campagne, e protegge il bestiame e gli orti. Per estensione è però anche il nume tutelare della proprietà e delle frontiere, come in effetti sono una frontiera territoriale, tra Roma e Veio, le stesse grotte in cui Silvano risiede.
Silvano è raffigurato come un vecchio vigoroso dalla barba irsuta, che vagabonda miseramente vestito, attento al controllo della frontiera e armato di un pesante tortòre per respingere gli invasori. Non si sa bene chi debbano essere gli invasori: sono Romani visti dalla parte etrusca, e viceversa. Selvans/Silvanus è una sorta di tertius arbiter, una figura neutrale dal carattere retto e bonario, che mal tollera però i cambiamenti dei limiti fissati. Proprio per questo a Silvano sono associati caratteri di burbero, insofferente alla vita associata e capace talvolta di manifestazioni grevi o persino misogine (avversava partorienti e neonati e spaventava i contadini facendo rimbombare nelle grotte la voce fragorosa).
Una leggenda attribuisce infine a Silvano un inusuale arbitrato nelle guerre etrusco-romane. In effetti, nei suoi libri sulla storia di Roma, Livio parla in tutto di ben 14 guerre, datate tra V e IV secolo a.C. Ma in realtà si tratta di poco più che battaglie, che scoppiavano ogni qualvolta le frizioni permanenti sfociavano in saccheggi. La guerra endemica contro i Veienti era insomma pazientemente sopportata, fin tanto che era possibile, e lo strumento delle «indutiae», le tregue pluriennali, era funzionale ad una mancanza politica a Roma per muovere una guerra su vasta scala al mondo etrusco che risolvesse la questione. Il conflitto si trascinava così stancamente, al punto che i due eserciti combattevano di giorno, e la sera, durante le sospensioni notturne, si incontravano quasi bonariamente, per assegnare la vittoria giornaliera, contando il numero dei rispettivi caduti.
Ad un certo punto il dio Silvano, stanco di questo massacro, infinito e assai poco virile, interviene proclamando a gran voce da dentro le grotte la vittoria ai Romani. Atterriti dalla roboante sentenza divina, gli Etruschi decidono da allora di rientrare nei confini.
Ritroviamo in seguito il dio Silvano con il nome di Marte-Silvano, essendo stato assimilato col tempo al dio Marte. Catone, nel De Agricoltura, riporta la cerimonia del «votum Martisilvani pro bubus uti valeant», per la salute del bestiame. L’offerta consisteva in un piatto di granaglie e pancetta rosolati nel vino («cocere in unum vas … farris, lardi, vini»), da ripetersi per ciascun capo di bestiame posseduto.
Un affare di famiglia
La leggenda di Silvano, tuttavia, come spesso accade, contiene una rappresentazione per metafora di una realtà storica. E la realtà storica è che dal 482 a.C. la guerra cambia registro, e finita la fase di stanca, riprende con una fase di rinnovato vigore che va sotto il nome di «bellum privatum» (Livio, II, 43). È una guerra privata perché ad animarla non è l’esercito di Roma, ma un’intera famiglia romana, la Gens Fabia, contrapposta ad un’intera città: Veio.
Tutto inizia quando il console Quinto Fabio Vibulano, della famiglia dei Fabii, reagisce all’ennesima scorribanda dei Veienti: quella che doveva essere però un’azione poco più che dimostrativa si rivela per i Romani una sonora sconfitta, e uno smacco personale per il console. Il console chiede rinforzi per vendicare l’affronto, e i Veienti chiedono rinforzi per ottenere una seconda vittoria. Parte da qui l’escalation e la corsa alla rivalsa della Gens Fabia.
Al console di rinforzi ne arrivano ben pochi. A Veio invece di rinforzi ne arrivano tanti. Specifica Livio: «non tam Veientium gratia concitata, quam quod in spem ventum erat discordia intestina dissolvi Rem Romanam posse», non per vicinanza spirituale a Veio, ma nella speranza che quella fosse la volta buona che Roma, logorata dalla lotta intestina, cadesse. La volta buona però non arriva per nessuna delle due parti in lotta: ogni anno, con la buona stagione, ripartono le ostilità, che la tregua invernale interrompe. E nessuna annata è quella risolutiva. Si instaura una situazione di pace armata in cui nessuno è disposto a perdere, ma nessuno ha abbastanza forza per vincere.
Il Senato di Roma, da parte sua, è contrario a muovere le legioni contro Veio, distogliendole dai fronti con Equi e dei Volsci. La Gens Fabia ottiene così dal Senato una sorta di delega in bianco, a condurre in proprio la guerra contro Veio. I Fabii si impegnano a finanziarla per intero, senza chiedere a Roma né un soldo né un soldato. I Fabii hanno il solo obbligo di compiere ogni azione in nome dell’autorità di Roma, per evitare, in caso di vittoria, che la Gens Fabia si secedesse da Roma rivendicando un regno suo. I Fabii conducono la loro guerra di famiglia con le stesse tecniche del nemico: la guerriglia. Li provocano, gli rubano mandrie e raccolti, e li portano ogni volta sino al punto di scendere a dare battaglia in campo aperto, fermandosi però un attimo prima.
E si arriva così al primo reale episodio di guerra combattuta. Nel 477 i Veienti, temibili e determinati, attendono l’esercito dei Fabii presso il torrente Cremera, li sorprendono, e con un’azione in larga scala uccidono fino all’ultimo componente della truppa dei Fabii. Riesce a salvarsi solo Quinto Fabio Vibulano. I Vienti prendono coraggio e muovono un esercito alla volta di Roma, riprendendo il controllo del Gianicolo, loro antico avamposto. È qui che Vibulano guida un contrattacco, che costringe i Veienti al precipitoso abbandono del Gianicolo e al ritiro entro le loro mura.
Inevitabilmente, ogni volta che il Gianicolo, come un interruttore, è chiuso o spento, le rotte commerciali si postano verso ovest, lungo le rotte dei torrenti, allora navigabili, che da Veio portavano al Tevere. Come il Rio Galeria, o il Rio Affogalasino, che sfocia proprio sotto le grotte di Montecucco. Le grandi grotte di Monte Cucco debbono essersi rivelate in questo periodo di grande utilità, soprattutto per lo stoccaggio delle merci in attesa di arrivare a Veio lungo il corso del Rio affogalasino.
Comunque, due anni dopo, siamo nel 475 a.C., i Veienti tornano ad attaccare, alleati dei Sabini, ed opposti a Romani, alleati latini ed Ernici. Ci sono i presupposti per una ripresa della guerra su vasta scala. Succede invece che la cavalleria di Publio Valerio Publicola ha la meglio e le azioni si fermano lì. Di lì a breve viene siglata un’altra tregua pluriennale, della durata di ben 40 anni. Roma è ben lieta di accettare, e rivolgere così le attenzioni militari ad Equi e Volsci. È un periodo burrascoso anche sul piano politico, del resto, in cui a Roma si instaura la dittatura dei Decemviri e vedono la luce le Leggi delle XII tavole.
La caduta di Fidene
La situazione torna a complicarsi nel 438 a.C., quando la colonia romana di Fidene si consegna al nuovo re di Veio, Lars Tolumna. Roma invia subito degli ambasciatori a chiedere spiegazioni e in tutta risposta Tolumna li fa uccidere. L’uccisione degli ambasciatori, contrario allo ius gentium, è la miccia che riapre la guerra. Il console Lucio Sergio Fidenate riporta delle vittorie, ma a grande prezzo di vite umane. Il suo successore, Mamerco Emilio, riprende le ostilità, portando la battaglia sotto le mura di Fidene. I Veienti, alleati dei Falisci, si difendono con grande valore. L’azione decisiva la compie il tribuno Aulo Cornelio Cosso, che vince in battaglia Tolumna e ne spoglia il cadavere, riparando l’oltragio subit dagli ambasciatori.
Nel 435 a.C. i Veienti ci riprovano. Tocca al dittatore Quinto Servilio Strutto respingerli e mettere nuovamente sotto assedio Fidene, che finalmente cade. La notizia della caduta di Fidene ha però grande risonanza il tutta la koinè etrusca, al punto che per la prima volta la questione tra Veio e Roma viene percepita come una guerra per la sopravvivenza tra due mondi alternativi: quello quello etrusco e quello romano. Per la prima volta si ha cioè la percezione dell’impossibilità di convivenza tra i due popoli. Dei messaggeri di Veio raggiungono le Dodici città del mondo etrusco, e convocano un’adunanza presso il Fanum Voltumnae, nell’attuale Orvieto. I rappresentanti della Dodecapoli, al Tempio, decidono però di non intervenire subito: i Veienti hanno aperto le ostilità con Roma, per ora se la sbrighino da soli.
È in questo momento che Roma riprende le armi contro Veio, per chiudere la partita. Neanche Roma, a dire il vero, dispone di grandi forze. Sorprendentemente i Veienti hanno la meglio, riprendono Fidene e fanno strage di coloni romani. Richiamato in fretta Mamerco Emilio alla carica di dittatore, Emilio ingaggia sotto Fidene la battaglia campale. I Veienti accettano finalmente la sfida in campo aperto e in un primo tempo hanno il sopravvento. La contromossa sono le cariche di cavalleria di Aulo Cornelio Cosso, che circonda gli attaccanti e compie a sua volta un massacro. Coloro tra i Veienti che riscono a fuggire si riversano sul Tevere, dove muoiono per annegamento. Fidene viene distrutta e gli abitanti vengono venduti come schiavi. Sulle rovine viene sparso il sale.
La caduta di Veio
Con lo scadere dell’ennesima tregua, nell’anno 408 a.C., la strada per Veio è aperta, e un ritardo da parte di Veio nel pagamento delle riparazioni di guerra, provoca la ripresa delle ostilità.
Un esercito di Romani composto da militari, guidato da tribuni militari, ottiene facili successi, e giunge fin sotto le mura di Veio, mettendo la città sotto assedio.
Con l’assedio della capitale nemica la guerra entra nella sua fase conclusiva. Eppure il Senato romano non ha una gran voglia di impegnarsi in operazioni militari, almeno fino a che le guerre con Vosci ed Equi sul fronte sud-orientale non si siano concluse. C’è poi il rischio che la Dodecapoli etrusca, di fronte al rischio della capitolazione di Veio, si decida e muova guerra a Roma, aprendo un conflitto su vasta scala. Sul fronte etrusco però la nuova adunanza riunita al Fanum Voltumnae non ha fretta di accordarsi per dichiarare guerra a Roma.
La situazioni si sblocca quando Roma espugna Artena ai Volsci, e libera così truppe per dare la zampata decisiva a Veio. In quel tempo Veio attraversa dei sommovimenti interni, e elegge un nuovo re, che non gode del favore delle altre città etrusche. Gli alleati etruschi, riuniti al Fanum Voltumnae, così colgono l’occasione e rinviano il sostegno militare a Veio fino a che il nuovo re fosse rimasto al potere.
Roma nell’inverno di quell’anno non sospende, come consuetudine, le operazioni di assedio: paga invece il soldo ad un esercito stipendiato, affinché l’assedio a Veio non concdesse tregua. All’esercito stipendiato si aggiunge presto un esercito di volontari, proveniente dalla plebe romana. Qualche rinforzo per la verità arriva anche a Veio, da parte di Falisci e Capenati. La guerra ha una nuova fase di stanca, e in soccorso di Veio arrivano pure Falerii e Tarquiniesi.
Intanto a Roma succede un piccolo disastro: l’arrivo a Veio di poche milizie volontarie ma provenienti da tutte le città etrusche, lascia intendere al Senato che da lì a breve le città etrusche avrebbero davvero mosso guerra a Roma. Non vi era nulla di più inesatto: al Fanum Voltumnae si agitavano infatti venti di guerra, ma si pensava a tutto fuorché a Roma: il nuovo pericolo - i Galli Senoni di Brenno – minacciava infatti le frontiere settentrionali del mondo etrusco. Fatto sta che a Roma la notizia dei volontari giunti in soccorso di Veio giunge ingigantita, come se il contrattacco veiente fosse ormai imminente. In questo clima viene nominato dittatore Marco Furio Camillo, e viene proclamata come di consuetudine la legge marziale.
Furio Camillo imprime alla guerra l’accelerazione risolutiva. La narrazione di Livio (V, 19), sempre misurata, si apre qui in uno dei rari slanci lirici, e ci dà la misura del tornato morale dei Romani: «Iam Ludi Latinaeque instaurata erant, iam ex lacu Albano acqua emissa in agros, Veiosque fata adpetebant». Già i Giochi Latini erano stati aperti, già l’acqua dell’emissario del Lago di Albano nutriva i campi, e già il destino segnava la sorte di Veio.
Il nuovo magister equitum Publio Cornelio Scipione rimette ordine nell’esercito, indice una nuova leva, arruola truppe volontarie latine ed erniche, e si trasferisce a Veio, per seguire da vicino le operazioni di assedio. Furio Camillo intanto sbaraglia a Nepe gli alleti di Veio Falisci e Capenati, e giunge anche lui sotto Veio, prendendo parte all’assedio.
Improvvisamente però tutte le ostilità cessano. Questo episodio viene narrato da Livio con grande pathos, come se stesse raccontando le fasi finali della guerra di Troia. In gran segreto infatti tutti i militi romani vengono messi a scavare: si tratta dello scavo di una grande galleria, per arrivare a portare la guerra sin dentro Veio, aggirandone le mura. Racconta Livio che i soldati fanno turni di 6 ore a ciclo continuo, anche la notte.
Un altro aneddoto raccontato da Livio vuole che Furio Camillo, ormai prossimo a completare la galleria, abbia inviato emissari al Senato per chiedere cosa fare dell’immenso bottino che si immaginava di trovare a Veio. Il Senato, con una risposta che galvanizzerà la plebe romana, con un pubblico editto risponde grossomodo così: chi vuole il bottino di Veio, deve andarselo a prendere. È così che la plebe di Roma all’istate abbandona i lavori agricoli e si riversa in massa sotto le mura di Veio.
Furio Camillo scatena improvviso un assalto alle mura di Veio, che in realtà è un diversivo, ma i Veienti ci cascano in pieno. I Veienti accorrono in massa a difendere le mura cittadine. Ed è in quel momento che l’Esercito Romano penetra a Veio dalla galleria scavata sin nel cuore della città etrusca. Ogni resistenza viene soggiogata nell’arco di una giornata. L’anno è il 396 a.C.. Ed è la fine di Veio. Il saccheggio della città, la deportazione dei Veienti, e la ripartizione dell’Ager Veietanus tra la plebe di Roma chiudono definitivamente la partita.
Un contratto del 1451
Delle Grotte di Monte Cucco si torna a parlare nel Medioevo.
Se ne parla in un contratto data 14 novembre 1451. I contraenti sono un tale Paluzzi Ponziani ed un tale Ceccolella, per la vendita di «sette cavallate di mosto» in località «Grotte del Trullo dei Massimi». La «cavallata» è un’unità di misura fiscale, che equivale al mantenimento per un anno di un soldato a cavallo, cavallo compreso. Con un grande approssimazione potremmo stimare una cavallata in 50.000 euro, e in 350.000 il valore del mosto. È una somma davvero ingente, che lascia intendere come le Grotte siano diventate una sorta di cantina vinicola per lo stoccaggio dell’intera zona circostante, coltivata a vigna.
Scrive Venditti: «Il mosto trasportato in questa descrizione conferma l’esistenza di grossi appezzamenti di terreno coltivato a vigna in tutto il comprensorio. Tutte le colline che da Monte Verde ed il Portuense si estendono fino alla piana del Tevere ed all’inizio dell’Agro Romano, con i loro declivi assolati, si adattavano magnificamente alla coltura viticola, a cui i Romani da sempre volentieri avevano rivolto l’attenzione».
Lo stesso Venditti riporta dell’impianto su queste colline, a inizio del Cinquecento, di un pregiato vitigno spagnolo, in sostituzione delle uve locali. Il promotore di questa iniziativa sarebbe stato Papa Leone X dei Medici, «toscano e raffinato intenditore del buon vino, anche se malaticcio e sofferente di stomaco» (Venditti).
Nell’anno 1547 ritroviamo le grotte citate nella carta topografica di Eufrosino della Volpaia. In essa è scritto, e persino disegnato, il toponimo «Grotte delle Fate». Nel suggestivo nome rimane traccia di un’area magica di questo luogo, che si portava forse appresso dall’apoca del dio Marte Silvano.
Sappiamo inoltre che intorno alle grotte sorgeva un casale, la cui traccia è stata individuata dal Tomassetti. Tuttavia a fine Cinquecento, del «Casale della Grotta delle Fate» non vi è più traccia, ed il al suo posto il latifondo è indicato con un generico «hoggi vigna».
I rifugi antiaerei del Genio
Ulteriori sistemazioni delle gallerie avvengono durante la Seconda guerra mondiale, con l’annessione all’impianto del Genio di Trullo e Magliana e la loro trasformazione in deposito militare e rifugio antiaereo.
Esiste una memoria popolare al riguardo. Essa vuole che, alla conclusione della Seconda guerra mondiale, le grotte siano state stipate di armi e per sempre murate.
Da informazioni prese dagli attuali frequentatori di Montecucco pare che oggi sia possibile entrare dentro le grotte attraverso le cantine di Torre Cocchi e di Villa Baccelli, e ovviamente dal Genio militare. Un’apertura presente nella Collina di Montecucco è ancora oggi presente ma si sconsiglia di percorrerla. |
|
Le Grotte di Montecucco, monografia pp. 2 di Antonello Anappo, in Biblioteca (Sala 2) inv. 87 /B
Vedi anche:
Grottoni
Pozzo Pantaleo medie…
Genio
Mira Lanza, lotto de…
Bunker
Caduti del Trullo

Borghetto agrario di Montecucco. Alle spalle le grotte di Montecucco (foto di Antonello Anappo, altre 81 immagini nel Fondo fotografico)
scheda inventariale
Inventario
|